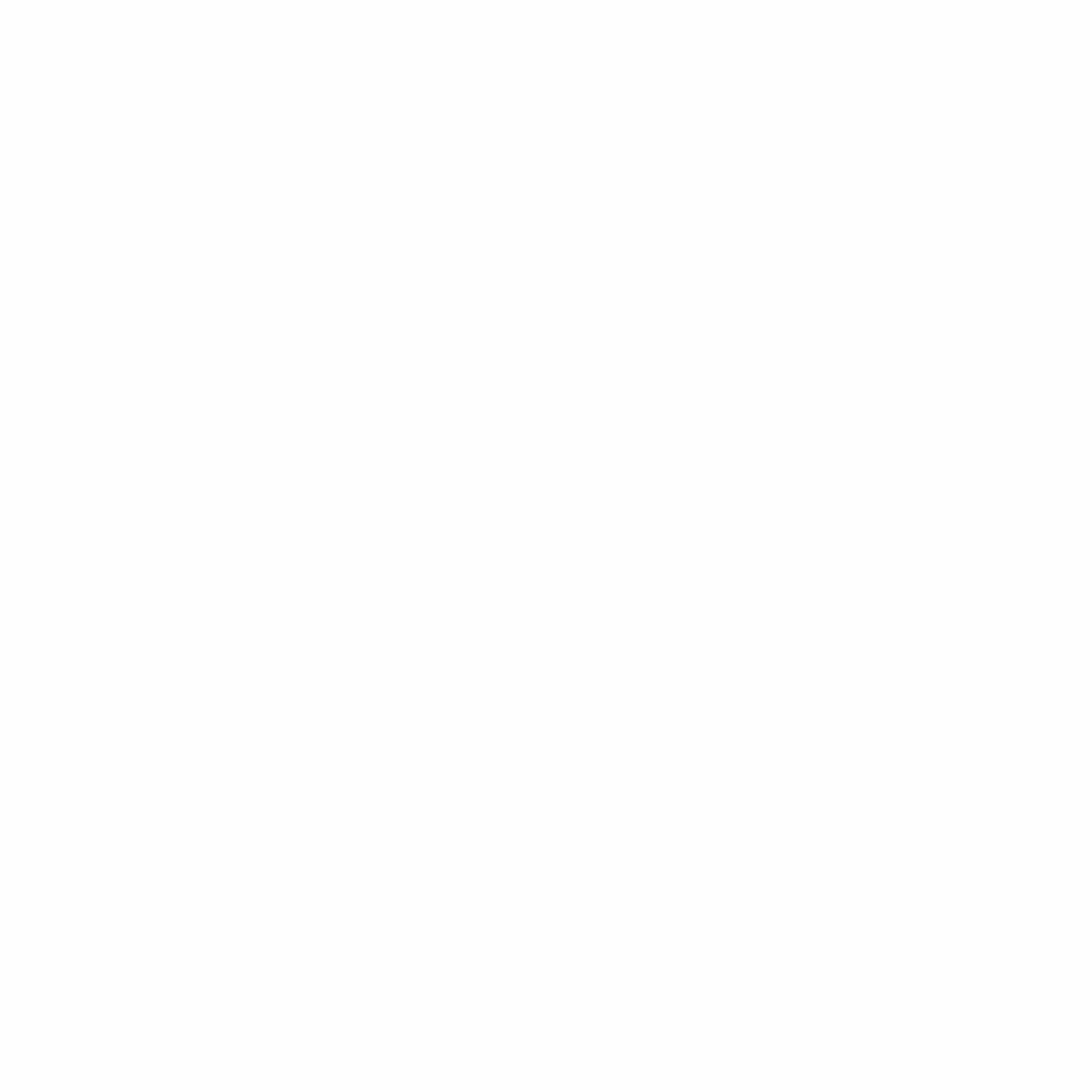Virginia Scirè è la fondatrice e Ceo di Wear Me, piccola impresa che in tre anni ha quintuplicato il fatturato. Grazie a un’idea e a prodotti di abbigliamento di babywearing che piacciono ai clienti e a un metodo di lavoro che premia l’inclusività di donne e mamme.
di Andrea Ballocchi
Ma chi pensa alle donne nel mondo del lavoro? In Italia sono in pochi a farlo. Più di 7 milioni di donne risultano inattive tra i 30 e i 69 anni sono davvero tante. Rappresentano il 43% del totale delle donne in questa fascia d’età. Una percentuale decisamente alta, quella italiana, rispetto alla media europea, in cui le donne che non lavorano né cercano occupazione sono il 32%, riporta una indagine di Randstad Research.
Ecco allora che quando c’è un’impresa “controcorrente”, fa notizia. Un esempio è Wear Me, un’ex startup costituita nel 2018 e che ha iniziato le attività nel 2019, sfiorando i 200mila euro di fatturato.
Quest’anno dovrebbe chiudere intorno al milione di euro, e probabilmente lo supererà. In anni caratterizzati dalla pandemia e dalla crisi che hanno vissuto molte imprese e settori, questa giovane realtà italiana che ha puntato sul babywearing, cioè la pratica di “indossare il bambino” portandolo a contatto con il proprio corpo, è riuscita a moltiplicare le entrate. Ed è riuscita a farlo grazie alle proprie idee, che passano dall’elevata qualità dei propri capi di abbigliamento, disegnati ad hoc con brevetti e disegni industriali, e che si fondano sul lavoro agile e sull’attenzione prioritaria alle esigenze dei propri dipendenti, per la maggioranza donne e mamme.
Questa giovane impresa è nata dall’intuito e dall’impegno di Virginia Scirè, 44 anni, imprenditrice con una laurea in economia e mamma di due figli. La sua è una storia già sentita: il lavoro in una importante azienda finanziaria, la proposta di un contratto full time e la conseguente necessità di lavorare a una certa distanza da casa, con un bimbo con problemi di salute. A quel punto c’è da decidere. E Virginia decide di licenziarsi, ma non intende lasciare il mondo del lavoro. Così, racconta, approfitta del restante periodo della maternità per reinventarsi. Decide di aprire un negozio di abbigliamento per bambini online, con un piccolo investimento iniziale, e nel 2010 avvia il suo primo e-commerce, iniziando a lavorare da casa. E ponendo le basi per quella che sarà più avanti l’avventura di Wear Me.
«Oggi del team fanno parte quattro persone che lavorano come dipendenti, oltre a me. E poi abbiamo anche sei collaborazioni in partita Iva che lavorano da remoto nel team marketing», racconta Virginia, segnalando che l’azienda è strutturata con una modalità di lavoro agile e in smart working, già prima delle necessità conseguenti al Covid-19.
Da dove nasce Wear Me?
«Quando sono partita ero da sola insieme a una dipendente che aveva tre figli. Ho cercato di costruire l’azienda in una modalità sostenibile. Sono partita dalle mie necessità di mamma e di persona con delle esigenze. E così ho pensato alla mia collaboratrice e anche alle persone che in futuro avrebbero iniziato a collaborare con me. La prima decisione che ho avuto è stata di chiudere alle 16.00 perché era un orario che permetteva di gestire tranquillamente la famiglia. E la seconda possibilità che ho fornito da subito a tutti è stata di contare sulla flessibilità oraria in entrata e in uscita. Gli orari sono stati concordati per aiutarle nel portare a scuola i figli, andarli a prendere, tenendo conto anche del percorso e del tempo necessario per gestire tutto. E ho dato loro la possibilità di lavorare in smart working: metà del team lavora da remoto. Con alcuni ci vediamo una volta al mese, con altri almeno una volta alla settimana».
La sua giovane azienda è costituita per lo più da donne, a loro volta mamme. Quali sono i motivi di questa sua scelta?
«Il motivo per cui io assumo per lo più donne è legato innanzitutto al tipo di lavoro che svolgiamo e al target di clienti che abbiamo, e richiede preferibilmente persone di sesso femminile e in particolare di mamme, soprattutto le persone che lavorano in ufficio con me, perché riescono meglio a stabilire empatia con le nostre clienti, costituite per lo più da altre mamme, e più inclini a comprendere le loro necessità e bisogni. Inoltre ho sempre cercato di dare una seconda possibilità lavorativa a persone che erano uscite dal mercato del lavoro proprio perché neomamme. Ho dato loro la possibilità di rientrarvi perché tantissime donne, dopo essere diventate madri, perdono la loro occupazione o sono costrette a farlo perché, nel momento in cui fanno richiesta di un part-time, spesso non viene loro concesso e si trovano a rinunciare alla loro mansione. Questo è un problema grave per il quale non viene fatto nulla. Non esistono incentivi a livello fiscale per chi assume una neomamma che ha perso il lavoro. Come imprenditrice non ho alcuna convenienza a concedere il part-time ai miei dipendenti perché è decisamente più oneroso rispetto a un full-time. Ma lo faccio per una precisa scelta, personale prima che imprenditoriale».
Wear Me è stata selezionata insieme ad altre quattro startup dall’incubatore Social Fare Torino. Che ripercussioni positive avrà questa opportunità per la sua realtà?
«Wear Me si è sempre autofinanziata. Sono partita con le mie risorse e il mio lavoro e la crescita che ho avuto nei primi tre anni è stata frutto del reinvestimento totale dei ricavi. Avviare questa attività è stato molto difficile per la grande difficoltà nel trovare investitori. Ho fatto tantissime presentazioni della mia impresa, ma nessuno ha creduto nel progetto e ho ricevuto tantissimi riscontri negativi, tante porte in faccia. A un certo punto ho anche smesso di cercare sostenitori. I motivi alla base dei rifiuti a supportare un progetto quale Wear Me erano legati ai dubbi sui numeri e sul fatto che potesse essere un progetto scalabile. I fatti mi hanno dato ragione e così quest’anno, avendo chiuso un buon 2021, ho deciso di partecipare alla selezione di Social Fare, l’ho superata e sono stata finanziata da loro attuando il programma di accelerazione. Devo ammettere che è stato molto utile perché il finanziamento ottenuto mi ha permesso anche di assumere nuove risorse. Inoltre, ho potuto puntare maggiormente sul marketing e svolgere una formazione che ha consentito di crescere, passando dallo status di startup ad azienda».
Quali aspetti del programma di accelerazione ha apprezzato maggiormente?
«Ho trovato particolarmente utile la parte dedicata alla fiscalità e alla gestione economica dell’azienda, così pure quella riguardante l’impatto sociale. Su quest’ultimo aspetto, devo ammettere che sono più consapevole della bontà del lavoro svolto e delle positive conseguenze dopo che è stato pubblicato il primo articolo a giugno e, a seguire, l’attenzione mass mediatica ottenuta poi. Ho compreso che il nostro modello lavorativo è di esempio».
Ha mai fatto domanda di finanziamenti pubblici?
«Sì, abbiamo partecipato a moltissimi bandi, perdendoli tutti. Personalmente sono molto delusa dalla modalità di accesso. Ho investito molti soldi per partecipare a questi bandi e tanto tempo. La compilazione delle domande per accedere al bando richiede in media come minimo 20-30 ore lavorative. Inoltre i fondi sono insufficienti. Tutti i bandi di Invitalia funzionano con il click day e nel momento in cui ci si collega e si invia anche immediatamente la domanda, questa viene rifiutata. Per quanto riguarda altri bandi, sono riuscita ad accederne a uno solo, della Regione Veneto, per una ristrutturazione del nostro ufficio. Anche in questo caso il riscontro è stato negativo. Per ottenere 12mila euro è stato un calvario. Per questo evidenzio tutta la mia delusione sulle forme di finanziamento pubblico. Non sono uno strumento che supporta le aziende come la nostra. L’impressione è che si faccia tanta pubblicità, ma poi i soldi di fatto non ci sono. Nell’ultimo bando a cui abbiamo partecipato venivano stanziati fondi per complessivi 200 milioni di euro, eppure dopo appena pochi secondi erano già finiti. Non so chi siano i fortunati che riescono a ottenere tali fondi. Posso solo dire che con l’azienda che conduco, che conta su personale quasi del tutto femminile e su diversi brevetti e un bel progetto imprenditoriale, non riusciamo ad accedere a finanziamenti di nessun tipo, malgrado le tante domande fatte, anche ricorrendo a società di consulenza».
Quali sono gli elementi che hanno decretato i positivi risultati di Wear Me?
«La nostra community, innanzitutto, che è costituita da persone che ci seguono e si ritrovano nella nostra realtà perché e comunichiamo valori in cui si riconoscono. Contiamo su clienti che acquistano perché, oltre a riscontrare l’ottima qualità dei nostri capi di abbigliamento, sanno che cosa c’è dietro il progetto e lo sostengono. Tuttavia, al di là delle idee che posso avere avuto e della community che abbiamo costruito, il riscontro positivo è legato al motivo per cui è nata questa azienda, cioè diffondere la pratica del baby wearing. È un concetto nel quale credo e lo considero quasi una missione. Ci tengo che i genitori possano stare a contatto con i propri bimbi perché fa bene ai loro figli, ma fa bene anche a mamme e papà. È una sorta di terapia a beneficio reciproco. Abbiamo speso tantissimo tempo nel fare divulgazione gratuitamente sui social e questo credo sia il motivo alla base dei nostri risultati positivi. Sono anni che io e il mio team facciamo comunicazione dedicata».
Ma c’è anche il benessere aziendale?
«Certo, anche il benessere aziendale supporta il successo di Wear Me. Qui le persone stanno bene e trasmettono energia positiva alle persone con cui si rapportano. Anche da noi non mancano momenti di difficoltà, però sono molto meno rispetto alle tante aziende in cui le persone lavorano affrontando disagi e stress. Sono profondamente convinta che, indipendentemente dal fatto che si tratti di donne, uomini, genitori o single, il sistema lavorativo italiano vada rivisto, puntando su orari più umani e uno stile di vita decisamente più sostenibile».
Per il prossimo futuro quali idee intende mettere in atto per consolidare ulteriormente Wear Me?
«Stiamo lavorando per ampliare l’impiego delle fibre naturali. Abbiamo lanciato una linea di intimo donna, di seta e per uomo, e ne introdurremo presto anche una per bambino. Crediamo molto nelle fibre naturali, per il loro valore ecologico e “circolare”, ma anche perché contribuiscono al benessere delle persone. Punteremo, inoltre, all’espansione sia sul mercato italiano sia guardando all’estero. A questo proposito, inizieremo la vendita in Francia, Paese che abbiamo deciso di provare a esplorare, e intendiamo farci conoscere in Europa perché siamo l’unico brand italiano che produce questo tipo di prodotti».
Quali consigli si sente di dare alle tante donne e mamme che hanno un’idea imprenditoriale ma temono di non farcela?
«Il primo consiglio è che ci vuole tanta forza di volontà. Nel momento in cui si decide di avviare un progetto, occorre metterci tanta energia e tanto lavoro, sacrificando tempo e risorse. Spesso, all’inizio, ho dovuto rinunciare al tempo libero e mi sono ritrovata, dopo aver messo a letto i miei figli, a rimettermi al lavoro. Non è una passeggiata avviare un’impresa. Dietro a ogni impresa c’è sempre tanto lavoro. Un altro consiglio è partire dai dati. Non ci si deve buttare alla cieca in un progetto, ma occorre studiare il mercato, preparare un business plan e soprattutto verificare che sia economicamente sostenibile».