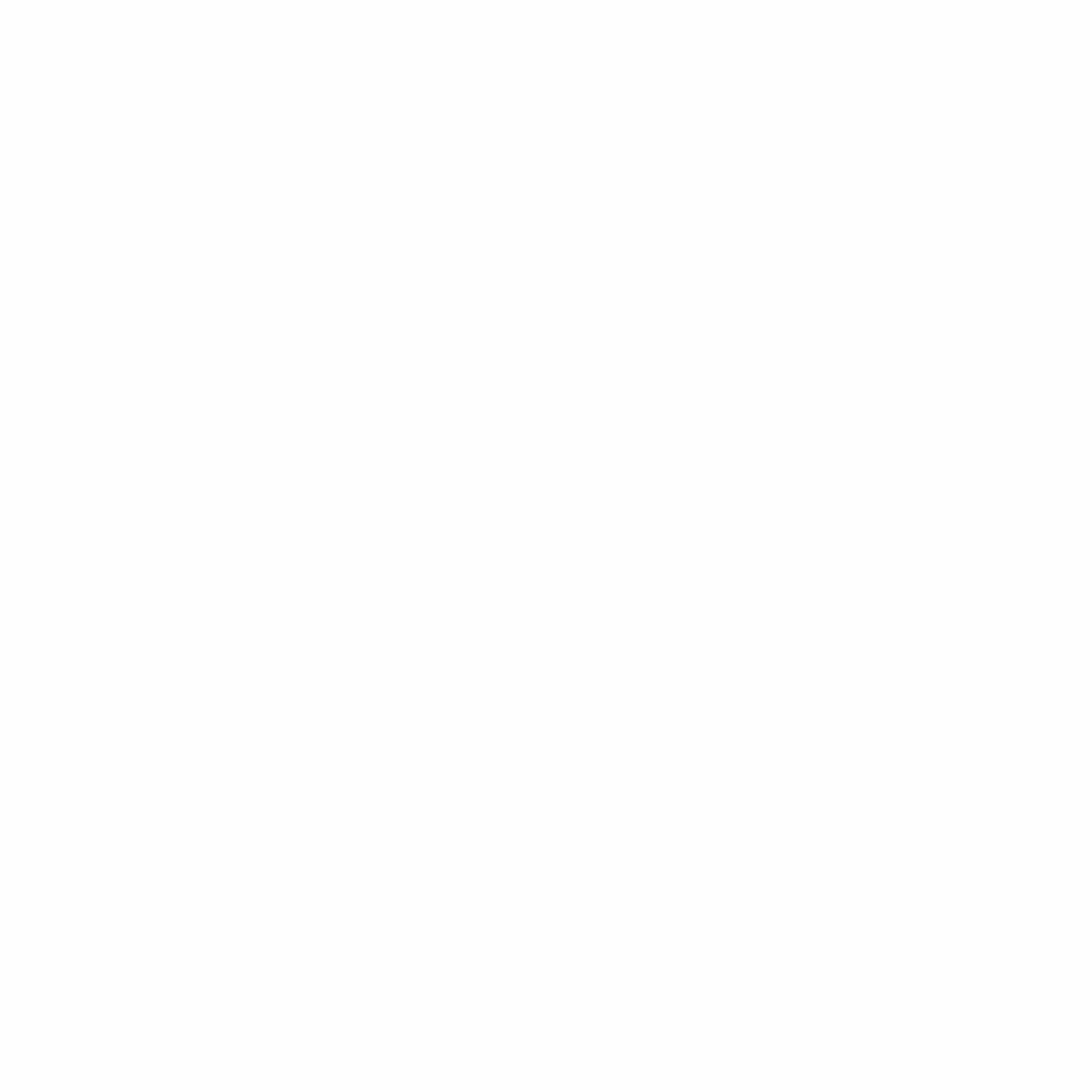Nella sua ultima opera Paolo Crepet affronta il complesso tema degli scenari postpandemici e riflette su alcuni fenomeni che si manifestano con sintomi deprecabili e, si spera, del tutto transitori. Lo abbiamo voluto incontrare per una breve intervista.
di Alessandro Battaglia Parodi
Sono molti i temi che lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet affronta nel suo ultimo libro Oltre la tempesta, un titolo dal sapore shakespeariano. La Dad e i problemi della scuola, lo smart working, l’odio sui social networks, il solipsismo delle relazioni e il fight club degli adolescenti in piazza sono fenomeni in parte conosciuti ma fortemente esasperati dalla pandemia. Alcuni di essi hanno tuttavia l’opportunità di trasformarsi in senso positivo e comunitario. A partire dalla filantropia. Ne parliamo con l’autore, partendo dalla grande occasione offerta dal Pnrr.
Non pensa che l’ingresso sulla scena pandemica del Recovery Fund possa garantire, un po’ come fece il Piano Marshall postbellico, quell’entusiasmo per le nuove idee, quella vitalità, quella bellezza, e quella progettualità collettiva che auspica nelle pagine del suo libro?
«Ho parecchi dubbi rispetto alla percezione che la gente ha del Pnrr e di tutto ciò che gli gira intorno. Se lei parla all’italiano medio, stia sicuro che la cosa non solo non gli interessa ma non la capisce neanche. Agli italiani di quel che fa l’Unione Europea gli preme ben poco. Se lo sforzo economico del Recovery Plan viene trasformato in opere e strutture, allora sì che inizieranno a pensare qualcosa di positivo. Altrimenti niente, la percezione è bassissima».
E perché secondo lei?
«Perché noi storicamente non abbiamo uno spirito comunitario ma veniamo da una cultura della delega, come diceva correttamente Montanelli. Siamo un Paese cattolico e individualista, da sempre piegato alla cortigianeria e alla delega d’ogni responsabilità personale. In secondo luogo c’è un altro bel problema, che non è neanche tanto piccolo. Siamo un Paese che ha come primo fatturato quello del malaffare, delle mafie, quelle dei colletti bianchi, ma anche quello dei misfatti delle banche e delle ruberie della politica. È chiaro che, a livello di percezione, il Recovery Fund viene interpretato un po’ da tutti come una grandissima mangiatoia. Poche briciole arriveranno ai cittadini, se mai arriveranno, è ormai questo ciò che pensa l’italiano medio. E quest’ombra si ripropone ogni qual volta c’è un grande evento alle porte, che sia un’olimpiade, un giubileo, la ricostruzione di uno stadio o un grande intervento infrastrutturale. Tutto questo inquina il sogno di poter avere un “credito”, parola complicata dal punto di vista filosofico, che permetta di costruire qualcosa di duraturo dal punto di vista sociale e comunitario. Giustamente l’Europa ha messo dei paletti a questo credito, e la riforma della Giustizia, ad esempio, è solo uno di questi paletti».
Nel libro lei fa numerose digressioni nel mondo urbano e cittadino per auspicare un “rammendo sociale” che coinvolga in anche i soggetti e l’iniziativa privata. Cioè quei filantropi che lei tratteggia evocando la figura del “Magnifico” e che oggi mancano totalmente. Perché sono assenti?
«È difficile dirlo. Quello che è venuto a mancare negli ultimi decenni è la figura del magnate alla J.P. Morgan. I vari Olivetti, Marzotto, Crespi o il vecchio Agnelli, tanto per intenderci. Sto parlando di quegli industriali che, in un momento storico particolare dell’economia italiana hanno legittimato il proprio ruolo di esponenti del ceto dirigente costruendo opere pubbliche molto utili, creando consenso intorno alle proprie imprese. E per far questo hanno creato luoghi di welfare, di protezione e di istruzione estremamente innovative per l’epoca. Ebbene queste figure tipiche del capitalismo patriarcale non erano mosse soltanto da un’esigenza egoistica ed erano interessate al mantenimento sociale e culturale del territorio su cui facevano poggiare i propri interessi. Oggi non è più così. Perché non ci sono le colonie Berlusconi? Perché non c’è un liceo classico a Parma intitolato a un industriale della zona? E ce ne sarebbero davvero tanti. Che cosa è successo nel capitalismo italiano, perché è così chiuso ed egocentrico? Solo perché le leggi di agevolazione fiscale non sono così consistenti e interessanti? Non direi proprio».
Se non le personalità illuminate, quali fenomeni ci porteranno fuori dalla tempesta?
«Qualche tempo fa ero all’Orto Botanico di Padova, il più antico al mondo e patrimonio Unesco. Ebbene ero vicino a una chiassosa scolaresca di adolescenti in visita, e a un certo punto vedo che tutti insieme si raccolgono a osservare le lente peripezie di un bruco su una foglia. Attenti, stupiti e affascinati da un banalissimo bruco. Ecco, in quel momento ho compreso il pericolo che grava sulle nuove generazioni, ormai ignare delle bellezze della natura, anche le più semplici, perché immersi costantemente in un mondo fatto di tecnologie e velocità, distante mille miglia dal reale. Ecco, bisogna ripartire da queste piccole cose, riappropriarsi del proprio tempo e iniziare a seminare consapevolezza. Io spero che la pandemia ci insegni almeno a rallentare i nostri comportamenti e a renderli più umani e responsabili. Penso quindi che le risorse del Recovery Plan disponibili per la società civile e per l’economia, che sono in gran parte a “debito”, ricordiamocelo sempre, siano più importanti per l’eredità di “umanità” che il Pnrr ci potrà lasciare. Vale a dire la coesione tra le persone e tra i territori, il cambiamento delle nostre abitudini e il recupero di una nuova dimensione collettiva».
Nelle ultime pagine lei accenna a uno dei sintomi tipici del Covid, la scomparsa del gusto. Una splendida metafora della drastica interruzione dei consumi in tempi di lockdown.
«La crisi, insieme ai mondi che essa crea da sempre, è ricchissima di metafore. Perdere il gusto è una grande metafora del perdere il gusto della vita, l’apice di un modello di consumi sbagliato e aberrante, dominato dalla velocità, dalla frettolosità dello sviluppo tecnologico, con la sua messaggistica istantanea e le sue continue interferenze tra tempi lavorativi e tempi di vita. Abbiamo distrutto il tempo, tutto è divenuto “istante”. E come lo ricostruiamo? Certo, non possiamo pensare che il tempo, e con esso il nostro futuro, si faccia da sé, si costruisca da solo. Dobbiamo realizzarlo noi nelle nostre relazioni, nei luoghi di lavoro, nella vita quotidiana. Dobbiamo tornare a darci complessità, dobbiamo tornare alla fatica del vivere. Ma cercando anche le cose più genuine e meno sofisticate, come ad esempio un incontro con gli amici che non vedi da tanto tempo o un semplicissimo panino con la mortadella. Cose divenute ormai straordinarie».