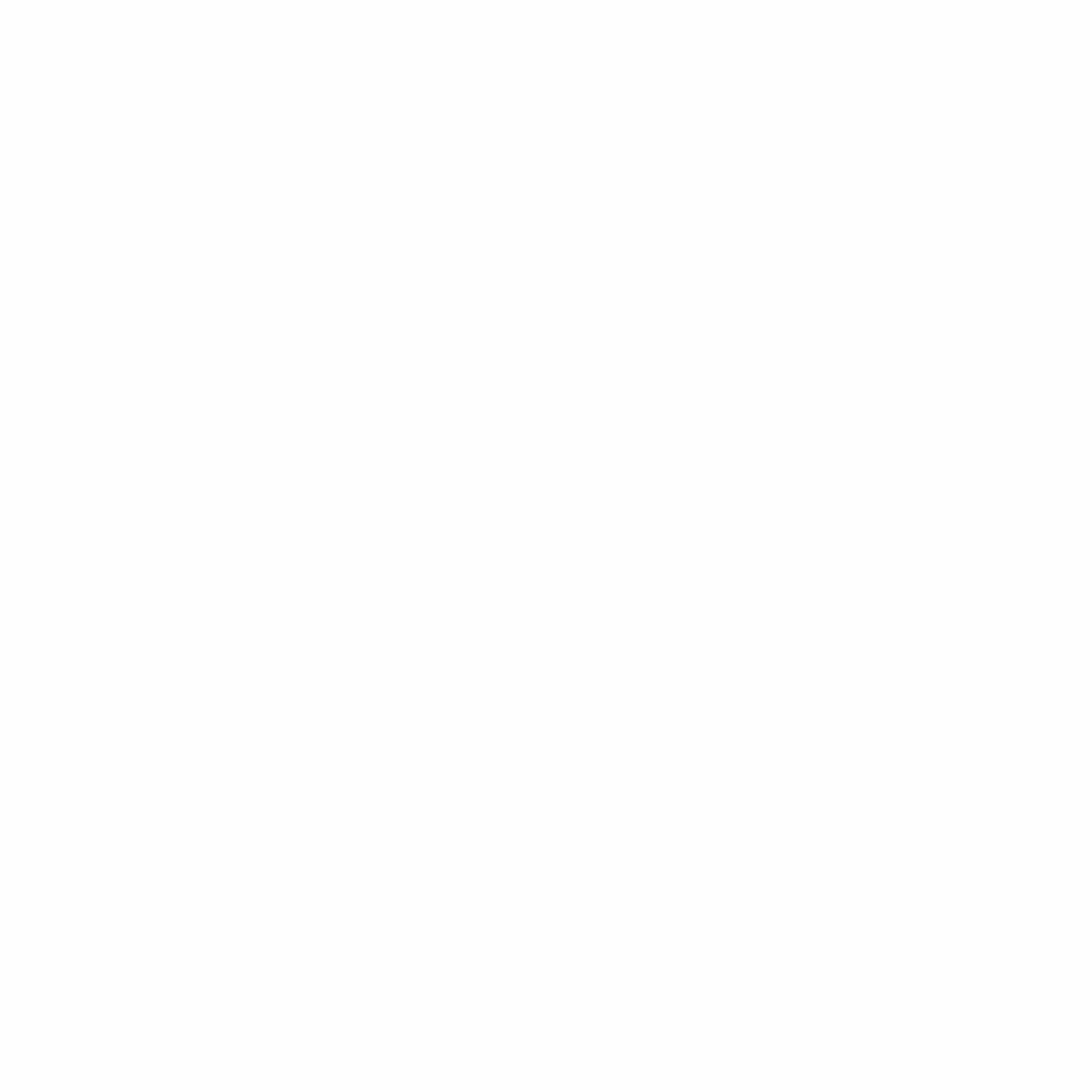Come nasce, come opera e cosa finanzia il più grande donatore privato al Sud. Quattro chiacchiere con Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione dal 2009.
di Marco Ehlardo
La Fondazione Con il Sud è il maggior finanziatore non pubblico del Terzo settore nel Sud Italia. Un ente che, dalla sua nascita nel 2006, ha sostenuto oltre 1.300 iniziative, coinvolgendo oltre 6.300 organizzazioni diverse tra non profit, enti pubblici e privati, e 430mila cittadini, soprattutto giovani, erogando complessivamente 245 milioni di euro.
Abbiamo intervistato Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione dal 2009. Una lunga chiacchierata sulla genesi della Fondazione, sui suoi obiettivi, sui nuovi bandi. Ma anche sui rapporti tra non profit e profit, e sullo stato del Terzo Settore al Sud.
La Fondazione nasce da un’alleanza tra Terzo settore e fondazioni bancarie. Queste ultime sono in gran parte del Centro-Nord. Come le avete convinte a investire in questa avventura?
«Non siamo noi ad averle convinte. Hanno deciso loro con un’iniziativa autonoma, tra il 2004 e il 2005, proprio perché c’è questa asimmetria italiana, per cui gli utili delle fondazioni di origine bancaria sono concentrati per oltre il 95% al Centro-Nord. A prendere l’iniziativa fu l’allora presidente della Fondazione Cariplo e di Acri, Giuseppe Guzzetti. Le fondazioni hanno dotato la Fondazione Con il Sud di un patrimonio di 320 milioni di euro, decidendo di trasferirle ogni anno 20 milioni. Grazie a questo, la Fondazione Con il Sud si può definire come una fondazione medio-piccola per patrimonio, ma medio-grande per erogazioni».
Quali sono le caratteristiche della Fondazione?
«Abbiamo una caratteristica unica in Europa: essere gestiti paritariamente da fondazioni di origine bancaria e da organizzazioni del Terzo settore. Il consiglio di amministrazione ha quattro rappresentanti delle prime e quattro delle seconde. Io sono una specie di arbitro. L’altra caratteristica originale è che siamo l’unica fondazione di origine bancaria che ha, come unica missione, quella del sociale. Ultima caratteristica particolare è la dimensione del territorio di riferimento: un territorio con oltre venti milioni di abitanti, ben più grande dei classici territori di riferimento di una fondazione bancaria».
Le parole, in italiano, sono importanti. Siete nati come Fondazione per il Sud, trasformandovi poi in Fondazione Con il Sud. Un semplice cambio di preposizione a prima vista. Cos’ha significato, invece?
«È stata una mia idea, di cui sono fiero. Lo scopo era passare da semplice fondazione di erogazione a qualcosa di più innovativo. Essere, cioè, partecipi anche della costruzione della domanda dei territori, in maniera collaborativa con gli stessi. Ci siamo ispirati a un concetto sviluppato da Danilo Dolci; lui diceva che non bisogna lavorare per i contadini poveri, ma con loro. Lavorare con, e non solo per, è diventato il principio della Fondazione».
Questo vale anche per alcuni vostri bandi
«A noi piacerebbe accompagnare le organizzazioni dall’idea al progetto. Portare avanti, dunque, una coprogettazione. In alcuni bandi possiamo farlo, in altri no. Un esempio è la nostra linea di cofinanziamento. Se viene da noi un’organizzazione che ha una buona idea, e un finanziatore privato disposto a metterci la metà del costo, l’altra metà la mettiamo noi. In questo modo il progetto lo costruiamo assieme. Altro esempio sono i bandi in doppia fase: nella prima fase selezioniamo le idee migliori, nella seconda fase accompagniamo i proponenti nella fase di progettazione esecutiva».
Dunque qualcosa di differente dai bandi pubblici, dove non ci sono momenti di condivisione, né prima né dopo l’uscita di un bando…
«Sì, e a questo proposito le dico qual è una delle frontiere che ci interessa di più: dimostrare che si può perseguire un obiettivo pubblico, e che si possono avere metodologie pubbliche, ma che si può fare con procedure private. Le faccio un esempio importante. La Fondazione finora ha erogato circa 245 milioni di euro in 11 anni; nel contempo l’impresa sociale Con i Bambini, interamente partecipata dalla Fondazione, che gestisce il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, in cinque anni ha erogato 330 milioni. Qualcuno può sostenere, in maniera ragionevole, che non si tratti di un intervento pubblico? Sono pubblici gli obiettivi; sono a evidenza pubblica i bandi; sono pubbliche le assunzioni. Non vengono scelti arbitrariamente i progetti, ma con selezione pubblica. Qual è la differenza con il pubblico? Che possiamo utilizzare procedure private. Quindi più flessibili, e, nel nostro caso, più partecipative. Ad esempio, durante la pandemia, abbiamo consentito, ai progetti già in corso, di fare sostanziali modifiche, visti i problemi. Sono cose che può fare una struttura flessibile, molto meno un’amministrazione pubblica, che è necessariamente più rigida».
La Fondazione promuove le reti territoriali, anche tra pubblico e privato sociale. Spesso queste reti, nei progetti, sono solo sulla carta. Come fate a verificarne la reale esistenza ed efficacia?
«Con la coerenza tra la presenza del partner e cosa fa nel progetto. Ogni partner, in fase di progettazione, deve aver assegnata un’attività concreta. Non ci interessano le mere firme sui progetti da parte di Università, Comuni, associazioni di categoria ecc. Non solo non ne teniamo conto, ma per noi è palesemente una causa di giudizio negativo. Il partner deve essere fattivamente impegnato nel progetto, altrimenti è inutile. Grazie a questa selezione tra reti reali e fittizie, nelle nostre valutazioni ex post (che si fanno fino a quattro anni dopo la conclusione dei progetti) abbiamo trovato numerosi casi in cui, anche se il progetto non è riuscito a sostenersi economicamente dopo il termine del finanziamento, i partenariati sono però sopravvissuti. Hanno continuato a lavorare assieme su altri fronti. Le reti vere, quelle che sopravvivono, sono quelle che si costituiscono non su una mera base organizzativa, ma soprattutto su un’analisi condivisa. Su un giudizio condiviso. Meglio ancora, su una politica condivisa. In un quartiere, la rete funziona se c’è un consenso sulle priorità, sulle responsabilità, sulle cose da fare».
Quali sono, secondo lei, i punti di debolezza del Terzo settore al Sud?
«Non ne vedo particolarmente al Sud. Forse l’unica osservazione da fare è che al Sud, per ovvi motivi, c’è una eccessiva dipendenza dalle pubbliche amministrazioni. Ci sono sicuramente due limiti, entrambi, però, in via di recupero. Il primo è che non si riesce ancora a fare la giusta differenza tra professionismo e professionalità. Il Terzo settore ha ancora un gap tra generosità, impegno e competenze necessarie. Professionalità significa gestione e cultura della rendicontazione. Una buona rendicontazione è anche cultura del risultato. Non va fatta semplicemente per il finanziatore, ma soprattutto per la stessa organizzazione. Il secondo limite è che molte volte il Terzo settore non si percepisce come soggetto di cambiamento e come soggetto politico. Anzi, in molti casi teme questa dimensione, quasi come se questa dimensione potesse mettere in discussione la mission originaria del Terzo settore. C’è infine ancora poca attenzione alla comunicazione e alla sua importanza. La comunicazione è uno strumento fondamentale di contaminazione dell’opinione pubblica. Su questo noi siamo molto attenti. La stessa Fondazione, su venti risorse, ne ha ben quattro addette alla comunicazione».
La Fondazione è molto attenta ai rapporti tra non profit e profit. I bandi prevedono sempre la possibile partecipazione di enti profit. Perché credete in questo rapporto?
«Ci crediamo perché abbiamo interesse, come dicevo prima, a contaminare e ad acquisire esperienze. Se in un progetto il ruolo di un ente profit può apportare competenze e innovazione per noi è benvenuto. Ovviamente il discrimine è che il privato non partecipi per fare profitti. Non deve, ovviamente, perderci, ma nemmeno guadagnarci. Sarebbe legittimo in generale, ma non appartiene alla nostra mission finanziare operazioni profit. Riguardo al nostro interesse per la collaborazione con il privato, credo che siamo in una situazione, culturale e politica molto interessante, in cui sta emergendo il grande tema della sostenibilità. Innanzitutto credo che vada riequilibrato, nel dibattito, il rapporto tra sostenibilità ambientale e sociale. La prima è molto presente e prevalente, la seconda meno. Ma è altrettanto importante, se non di più. In questo momento ci sono due percorsi speculari. Da una parte il profit si pone il problema della sostenibilità, della responsabilità sociale, e se lo pone meglio di prima, sia pur ancora con qualche limite. Dall’altra parte, il Terzo settore va acquisendo, sempre più, una dimensione imprenditoriale. Di questi due processi paralleli, il secondo è ancora troppo lento e va accelerato. Perché se i due processi non procedono di pari passo, si genererà confusione. Ad esempio, potremmo finire con le grandi aziende che vogliono spiegare al Terzo settore cos’è la sostenibilità sociale. E questo non va bene. Per accelerare questo processo, per esempio, la Fondazione ha investito 10 milioni nel fondo chiuso Social Impact, gestito dalla Sefea Impact Sgr (società di gestione del risparmio dedicata a istituire e gestire i Fia, Fondi di Investimento Alternativi, chiusi, ndr). È un fondo che fa equity nelle imprese sociali, l’unico in Italia. L’obiettivo è spingere le imprese sociali ad assumere una dimensione finanziaria corretta».
Perché il rapporto tra profit e non profit al Sud è ancora poco sviluppato?
«Ci sono ancora diffidenze reciproche, e bisogna avere ancora pazienza affinché questo rapporto si sviluppi. Le imprese vogliono essere molto sicure dell’interlocutore non profit, e quindi privilegiano le grandi organizzazioni nazionali piuttosto che le piccole organizzazioni locali. Una scelta comprensibile, ma non condivisibile. I pregiudizi, comunque, sono reciproci. Una parte del Terzo settore vede ancora il profit come il “nemico”. C’è bisogno di coltivare questo rapporto con pazienza. D’altronde io credo che in questa materia la cosa peggiore sia il corto circuito derivante dalla fretta di fare certe cose. La fretta fa enormi danni, che poi riallontanerebbero definitivamente i due settori».
È uscito da poco il nuovo bando della Fondazione sulla mobilità sostenibile. Come mai si è scelto questo tema in un momento storico in cui le difficoltà sembrano altre? Cosa vi aspettate dai progetti?
«È una scelta che può sembrare estemporanea, ma non lo è. Rientra nel percorso che abbiamo deciso quando è scoppiata la pandemia. Le possibilità erano due: continuare con le attività programmate o azzerare tutto e dedicarsi solo alla pandemia? Abbiamo scelto la prima. Anche perché, nel secondo caso, non potevamo incidere significativamente sul problema. Quindi abbiamo proseguito con le attività previste, e tra queste c’era questo bando, che è anche una provocazione. È ovvio che, con le risorse a disposizione, non ci si può aspettare di cambiare la mobilità delle città. Ma si possono fare piccoli esperimenti pilota nei paesi e nei quartieri. E noi ci aspettiamo soprattutto idee. E dal Terzo settore, in questi casi, arrivano tante idee, a volte apparentemente strambe, ma molto innovative. A noi interessa la doppia chiave della sostenibilità: quella ambientale, e quella di garantire l’accessibilità ai soggetti fragili agli strumenti di trasporto, che spesso sono pesantemente discriminati. Certo, ci aspettiamo molte idee già viste, come il bike sharing o i monopattini, ma siamo sicuri che verranno fuori anche idee molto interessanti e innovative».
Il bando sociosanitario com’è andato? I risultati si sapranno a breve?
«Sono arrivate proposte davvero interessanti, su entrambi gli ambiti previsti. Stiamo completando l’attività di selezione e penso che il prossimo Consiglio di aprile, o al più tardi quello di maggio, licenzierà la graduatoria. È stato un lavoro faticoso e complesso, le domande sono state numerose, ma questo è sempre positivo».
Una richiesta costante nei vostri bandi è di garantire una sostenibilità futura dei progetti al termine del vostro finanziamento. È sicuramente uno dei punti più difficili da garantire per un ente non profit. Come lo valutate?
«È un criterio di valutazione per noi importante, ma sappiamo come sia difficilissimo da garantire. Io dico sempre ai miei collaboratori che “non moriremo di business plan”. Significa che vogliamo, sì, capire la sostenibilità dei progetti, ma che in alcuni casi la sostenibilità significa altro da quella meramente finanziaria. Dopodiché ci interessa, per esempio, la capacità di penetrare la pubblica amministrazione o la capacità di fare fundraising. Siamo comunque molto soddisfatti, perché al momento circa il 70% dei progetti finanziati è proseguito anche dopo il termine del nostro finanziamento. Considerando che ci muoviamo in un ambito in cui non ci sono ricavi dalle attività delle organizzazioni, è certamente un risultato straordinario».