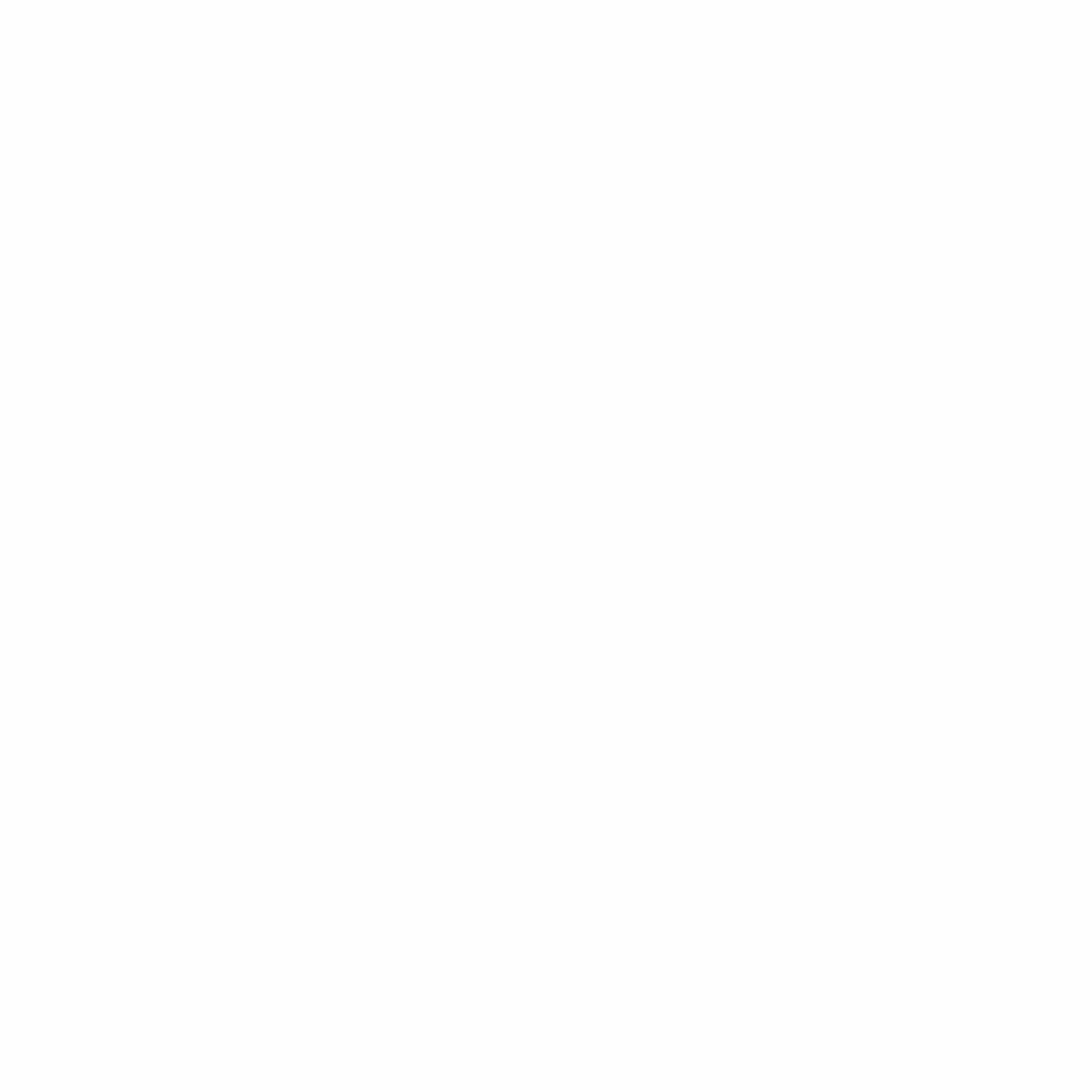Le organizzazioni non profit fanno già un lavoro eccellente con pochissimi mezzi a disposizione e occorre quindi offrire loro maggiori opportunità nel reperimento di risorse economiche. Ma manca ancora un serio orientamento alla managerialità e all’attuazione di una vision di lunga gittata. Intervista a Giovanna Paladino.
di Alessandro Battaglia Parodi
Con il Recovery Plan si rischia una distribuzione di risorse a pioggia senza una precisa valutazione delle priorità e senza una buona selezione. La domanda che tutti si pongono in questi giorni è come saranno spesi i fondi destinati al Terzo settore e se ci sarà un corretto accompagnamento dei tanti talenti presenti sul territorio nazionale. L’obiettivo è infatti la valorizzazione del merito per poter raggiungere risultati ancora migliori. Ci riusciremo?
Lo abbiamo chiesto a Giovanna Paladino, già docente di economia alla Luiss e responsabile della segreteria tecnica di presidenza di Intesa Sanpaolo.
Per la Commissione Europea il non profit e l’economia sociale sono fondamentali per il rilancio dello sviluppo economico. Ma il nostro Recovery Plan non sembra molto votato a valorizzare il grande potenziale di risorse di un Terzo settore che opera da sempre per l’interesse generale delle comunità. Lei che cosa ne pensa?
«La missione 5, di inclusione e coesione, del Pnrr è molto ampia e include tanto di quello che andrebbe fatto nel nostro Paese per non lasciare indietro nessuno. È vero le risorse del cosiddetto Recovery Plan sono limitate ma sono pur sempre il 10% del totale delle risorse messe a disposizione dalla Commissione Europa e insieme ai fondi React EU e a quello complementare raggiungono complessivamente quasi 30 miliardi, ovvero circa il 13 % dell’intero plafond».
Ma non pensa che sia però venuto a mancare il cosiddetto “principio di sussidiarietà” in questo piano, che è poi uno dei cardini del nostro impianto costituzionale?
«Non è certo possibile pensare al principio di sussidiarietà solo sulla base del sostegno fornito dai soldi pubblici. Le istituzioni, infatti, dovrebbero garantire le condizioni per permettere alla persona e alle aggregazioni sociali di agire liberamente e un intervento in loro sostituzione dovrebbe essere considerato temporaneo. L’Italia non rinascerà solo grazie a 236 miliardi di euro, che equivalgono a poco più del 10% del nostro PIL in tempi migliori. C’è bisogno di un coinvolgimento dei privati ed è necessario creare una partnership pubblico/privato che abbia chiari gli obiettivi, mantenendo una complementarietà dei ruoli. È fondamentale fare sistema. Senza la mobilitazione della finanza e delle energie del settore privato non si va da nessuna parte anche se il plafond a disposizione della missione di inclusione e coesione fosse più alto. La storia insegna. Nel dopoguerra, in Italia, senza la mobilitazione delle forze private il piano Marshall non avrebbe avuto gli effetti che ha dispiegato. Da questo punto di vista, dobbiamo ammettere che nel nostro Paese il Terzo settore, che è un catalizzatore delle energie dei cittadini più volenterosi, ha bisogno di fare un salto di qualità nel suo complesso. Esistono ancora moltissime piccole realtà che fanno affidamento solo sulla buona volontà dei singoli e che hanno difficoltà ad accedere a risorse perché mancano delle competenze necessarie a costruire progetti in grado di fare la differenza nelle comunità in cui vengono implementati».
C’è un elemento che l’ha colpita di più nella missione 5 del Pnrr?
«La missione 5 prevede il rafforzamento del servizio civile universale. Un modo per fornire ai cittadini, che vogliono impegnarsi in progetti a impatto sociale, quelle competenze utili nel momento in cui volessero perseguire la loro attività anche dopo il termine del servizio. Un rafforzamento dell’anima costruttiva del volontariato, ovvero di ciò che più serve al Terzo settore. Nella maggior parte dei casi, trovare il funding è una naturale conseguenza del modo in cui un progetto è pensato e strutturato, del modo in cui si assicura il suo monitoraggio e della dimostrata capacità di correggere la rotta qualora ce ne fosse bisogno».
Alcuni osservatori pensano che a lungo andare le organizzazioni senza scopo di lucro dovranno cercare di intercettare in modo diretto le proprie fonti di sostentamento, generandole quindi da sole o rivolgendosi ai privati. Secondo lei ci sono elementi meritocratici e positivi in tutto questo? E non c’è il rischio di assistere a un depauperamento generale e progressivo del panorama del Terzo settore? Una sorta di crudele selezione naturale, esattamente come avviene nel mondo dell’impresa?
«Penso che la cosiddetta meritocrazia sia utile anche se spesso non piace perché implica, da un lato, prendersi la responsabilità di fare una scelta e, dall’altro la capacità di accettare di arrivare secondi, cosa che di solito non piace a nessuno. È difficile valutare da soli il merito di quello che si sta facendo perché, come dicono i napoletani con grande saggezza, “ogni scarrafone è bello a mamma soja”. Ma quando si lavora con il sociale si lavora sulle speranze e sulle sofferenze delle persone. Non si può perdere tempo solo perché non si è pensato a come rendere più efficace il proprio intervento. Misurare l’impatto di ciò che si fa è una buona regola anche, e soprattutto, nel sociale, posto che il fine è determinare un cambiamento. Fare bene il bene non è semplice e la buona volontà è una condizione necessaria ma non sufficiente per fare la differenza. Dover concorrere per l’attribuzione di fondi privati attiva energie e idee. L’esperienza che abbiamo fatto in questi cinque anni al Fondo Beneficenza di Intesa Sanpaolo è che essere spinti a migliorare i progetti per poter ottenere il sostegno finanziario attiva strategie più efficaci ed efficienti sia dal lato dell’ente erogatore sia da parte dell’ente sostenitore. Usare le energie per costruire progetti meritevoli non è uno spreco di tempo. Fare senza sapere che cosa si sta facendo o facendolo male, solo per fare qualcosa, può servire a colmare il nostro bisogno di riconoscimento non certo a risolvere o a mitigare il problema che affligge il beneficiario delle nostre azioni».
Esistono, a suo parere di economista e docente, dei seri problemi culturali relativi alla capacità di fare business da parte dei manager italiani del Terzo settore? E perché manca questa mentalità orientata alla vision d’impresa?
«Non si può generalizzare. Capisco che si può sembrare insensibili, ma anche il Terzo settore dovrebbe adottare un criterio selettivo. Bisognerebbe distinguere l’elemosina dalla beneficenza. Due attività utili ma molto diverse tra loro. L’elemosina serve per affrontare in modo estemporaneo un’emergenza, la beneficenza ha bisogno di un progetto che determini un cambiamento, si spera duraturo, nella condizione di disagio iniziale. Secondo me per troppo tempo si è fatta confusione e a lungo è stato usato il criterio “del primo arrivato primo servito” per allocare fondi. La mentalità del “cherry picking”, ovvero della selezione trasparente e basata su criteri quali-quantitativi, non è ancora la normalità né nel pubblico né nel privato. Certamente non va mortificata la voglia di fare e di essere utili ma sappiamo benissimo che una buona organizzazione può fare miracoli. La managerialità non è sinonimo di capitalismo spietato ma semmai di efficienza rispetto all’attuazione della vision, che dovrebbe guidare anche l’impresa sociale. Teniamo conto che sempre più l’impresa cosiddetta “profit” si sta avvicinando a obiettivi sociali. Non è raro, infatti, vedere grandi corporation, per esempio nel settore alimentare o energetico, definire un purpose e trasformarsi in B-Corp. Mi auguro che anche il Terzo settore superi eventuali residui ideologici per adottare uno stile manageriale che consenta di fare bene il bene e di aumentare in modo significativo coesione e inclusione sociale».