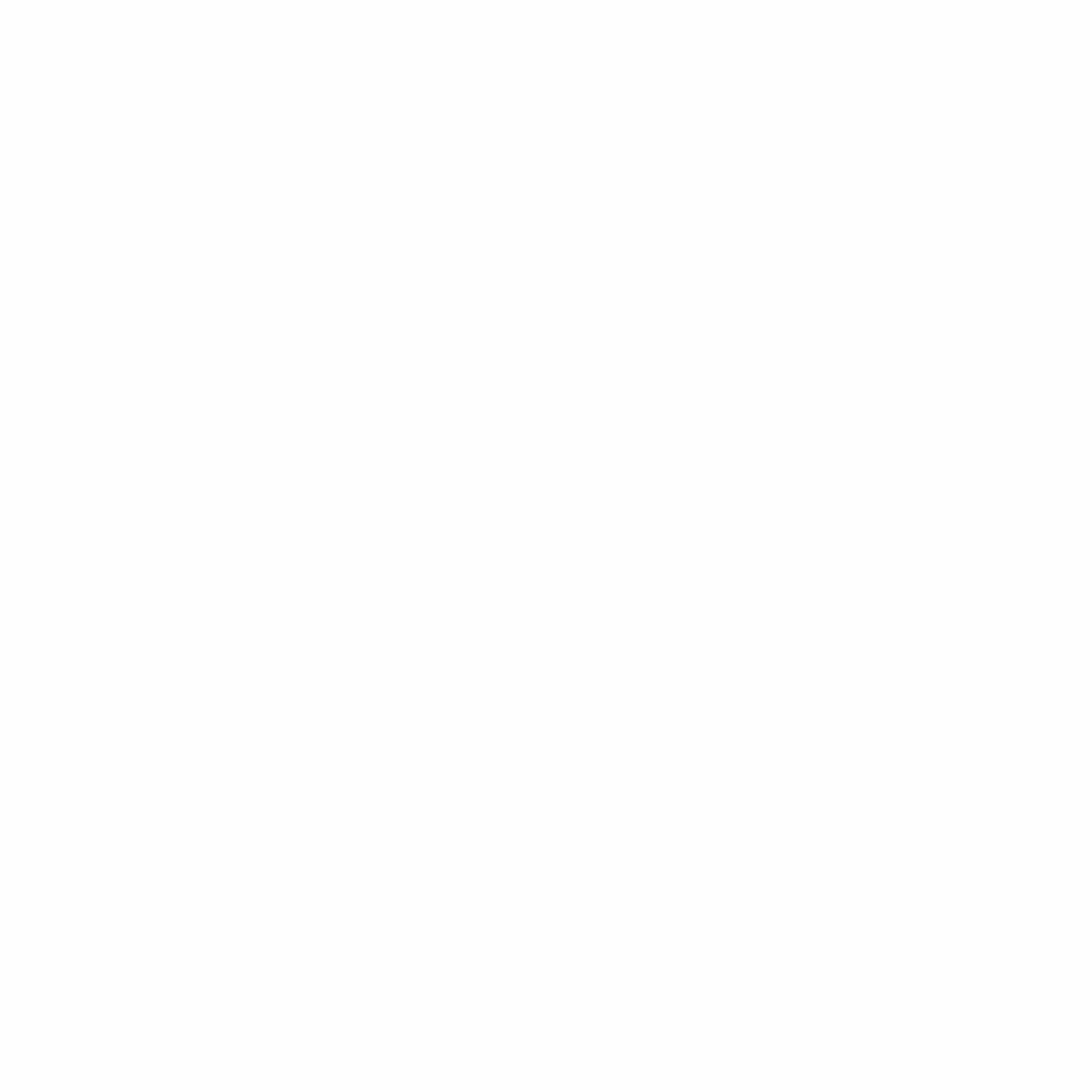Altana ha scelto di diventare società benefit devolvendo ogni anno il 10% degli utili. Un impegno di responsabilità sociale d’impresa che passa attraverso una rigida valutazione degli enti beneficiari da parte della fondatrice della società, Marina Salamon.
di Alessandro Battaglia Parodi
La notizia era davvero ghiotta: Altana Kidswear, azienda trevigiana specializzata nell’abbigliamento di lusso per bambini che serve brand del calibro di Gucci e Moschino, ha recentemente deciso di trasformarsi in società benefit modificando il proprio statuto e certificando la donazione del 10% dei propri utili a enti non profit che svolgono attività a forte impatto sociale o solidaristico. Abbiamo quindi preso subito contatto con Marina Salamon, presidente e founder di Altana, per capire se la scelta della responsabilità sociale d’impresa fosse un semplice strumento per differenziarsi sul mercato rispetto a concorrenti meno “responsabili”. E abbiamo scoperto tutt’altro. Quello che segue è l’esito della nostra conversazione.
Come siete arrivati a fare questa scelta solo adesso, considerando che Altana esiste dal 1982?
«In realtà ci siamo sempre comportati, anche in passato, in modo coerente rispetto alla cosiddetta “responsabilità sociale d’impresa”. L’unica cosa è che non si chiamava ancora così. E soprattutto non ne avevamo mai parlato. Per me è sempre stato un obbligo morale, fin da ragazza, la solidarietà. Pensi che, ad esempio, con gli utili del primo bilancio nel 1983 mi diedi l’obiettivo di arrivare a comprare una Jeep per un’associazione che operava in Africa, dove agivano come volontari alcuni miei compagni di liceo. E ricordo anche che la possibilità di rendermi utile fu un grande stimolo a essere imprenditrice».
Forse erano altri tempi e mancava ancora quella logica d’impresa volta a comunicare queste iniziative solidali?
«È possibile, sicuramente i tempi sono cambiati e ora si enfatizza qualsiasi cosa pur di fare bella figura. Sa, qui il tema è sempre quello della responsabilità personale. E quando si passa dal personale alle dinamiche della comunicazione d’impresa, il salto logico è davvero enorme. Si rischia sempre di perdere per strada molti elementi, che riguardano la sensibilità e la responsabilità individuale, appunto».
Quanti player privati sul mercato possono oggi permettersi di fare quello che avete fatto voi con Altana?
«Molti potrebbero già farlo, sia tra le piccole che tra le medie aziende, ma anche a titolo personale. Credo che dovremmo arrivare a diffondere un atteggiamento di filantropia maggiormente diffusa, sul modello del “giving pledge”, cioè donare in vita almeno metà dei propri averi in beneficenza. Un modello a cui hanno aderito negli Usa centinaia di persone ricche, su ispirazione di Bill Gates».
Perché qui in Italia non attecchisce questo spirito filantropico?
«Mah, credo per ragioni storiche e soprattutto culturali. Questo genere di iniziative rappresenta da sempre l’anima delle culture protestanti e in particolar modo di quella calvinista. Non occorre certo scomodare Max Weber per comprendere che il benessere generato dal lavoro, e il successo che ne consegue, ha per i protestanti un valore che supera la propria dimensione personale o di clan e va a incidere su tutta la comunità. In un processo di reinvestimento continuo. In Italia, Paese di tradizione cattolica, come la Spagna e il Portogallo, queste ricadute sono sempre state minori per ragioni, appunto, storico-culturali. Qui è più radicato il concetto di beneficienza inteso come carità. Che è cosa ben diversa dal reinvestire i frutti della propria attività per creare nuove iniziative che a loro volta generano valore. Ma sono convinta che presto questo modello arriverà anche da noi. La contaminazione tra le due culture si fa sempre più forte».
Con Altana avete mai realizzato iniziative di cause related marketing?
«Non credo di avere mai compiuto donazioni che includessero il cause related marketing, ma proprio perché non le abbiamo mai comunicate pubblicamente. Diciamo che ci sarebbero potute stare. Ma questa logica non ha mai fatto parte delle nostre policy di comunicazione istituzionale. In ogni caso conosco piuttosto bene questo tema perché, da consigliere nazionale del Wwf, per oltre 10 anni ho gestito le sponsorizzazioni da parte di grandi aziende verso l’organizzazione non governativa, allestendo diverse operazioni di cause related marketing dal 1982 al 1992».
A quali associazioni devolvete parte dei vostri utili?
«Noi devolviamo, ogni anno, il 10% dei nostri utili ante imposte a decine di associazioni, a cui in genere siamo fedeli nel tempo. Prendiamo infatti impegni triennali o quinquennali con loro. Sosteniamo soprattutto associazioni che operano nei Paesi in via di sviluppo, e solo in minoranza in Italia, a sostegno di progetti rivolti a donne e bambini con particolare attenzione ai temi dell’educazione, del microcredito e dell’avviamento al lavoro. Senza dimenticare la sanità, la protezione della natura e degli animali».
Può farci qualche nome?
«Non è proprio nel mio stile, ciononostante ritengo che sia ora di parlare liberamente di queste cose, se non altro per accendere i riflettori su tutte queste realtà che svolgono attività meritorie. Gliene nomino solo un paio di recenti, perché quelle che seguiamo da tanto tempo sarebbero davvero troppe. Ad esempio il Progetto Arca e l’Opera San Francesco a Milano, l’Antoniano di Bologna, la Scuola Oliver Twist di Como, e poi la Fondazione Guido Venosta, l’associazione Geos casa famiglia, la Comunità di Sant’Egidio con il Banco Alimentare fino ad arrivare al corridoi umanitari. Ma sono decine anche le onlus che sosteniamo in Centroamerica, come ad esempio la Fondazione Francesca Rava ad Haiti. Ma così, al telefono, ne sto dimenticando tantissime».
E perché ha scelto proprio queste?
«Devo dire che esamino personalmente e con grande attenzione i loro bilanci, e se vedo che c’è qualcosa che non va o che non mi convince, come le spese eccessive in viaggi o in comunicazione, l’accordo non si fa. Tendo a prediligere quelle realtà che hanno bassi costi di struttura, cioè non superiori al 20% delle entrate, e che hanno un alto impatto sociale. Insomma, non amo le associazioni a gestione troppo personalistica, i cui bilanci non siano assolutamente trasparenti».
Pensa che mettere in connessione i due settori, apparentemente inconciliabili, del profit e del non profit possa far storcere il naso ai puristi del Terzo settore?
«Penso che dipenda da ciò che si intende con l’espressione “mettere in connessione”. In che senso lo intendiamo? Qui c’è evidentemente un altro grosso nodo culturale. La sensazione è che l’ambiente del Terzo settore sia tradizionalmente impregnato di preconcetti ideologici, per cui tutto ciò che proviene dal mondo dell’impresa viene immediatamente etichettato spregiativamente come “capitalistico”, e quindi punti sistematicamente ad avere un suo tornaconto. Credo allora che il settore profit debba imparare ad attuare la responsabilità sociale con correttezza, e che il non profit debba invece migliorare alcuni aspetti formali, ad esempio la comunicazione e il marketing, inserendo al proprio interno competenze professionali mutuate dal mondo profit, disponibili anche a titolo gratuito».
E cosa si può rispondere a chi accusa aziende come la vostra di fare mere operazioni di marketing e di sgravio fiscale?
«Rispondo che mi occupo di filantropia e che utilizzo una parte del mio tempo a servizio del non profit da quasi 40 anni, e non l’ho mai comunicato. Fino a oggi, quando abbiamo deciso di trasformare le nostre aziende in società benefit. Solo ora ho scelto di parlarne pubblicamente, sperando di stimolare altre aziende a fare lo stesso. In quanto agli sgravi fiscali, è vero che per ogni 100 euro donati se ne risparmiano 25 di tasse, ma occorre anche dire anche che gli altri 75 resterebbero nelle casse aziendali, se non fossero donati».