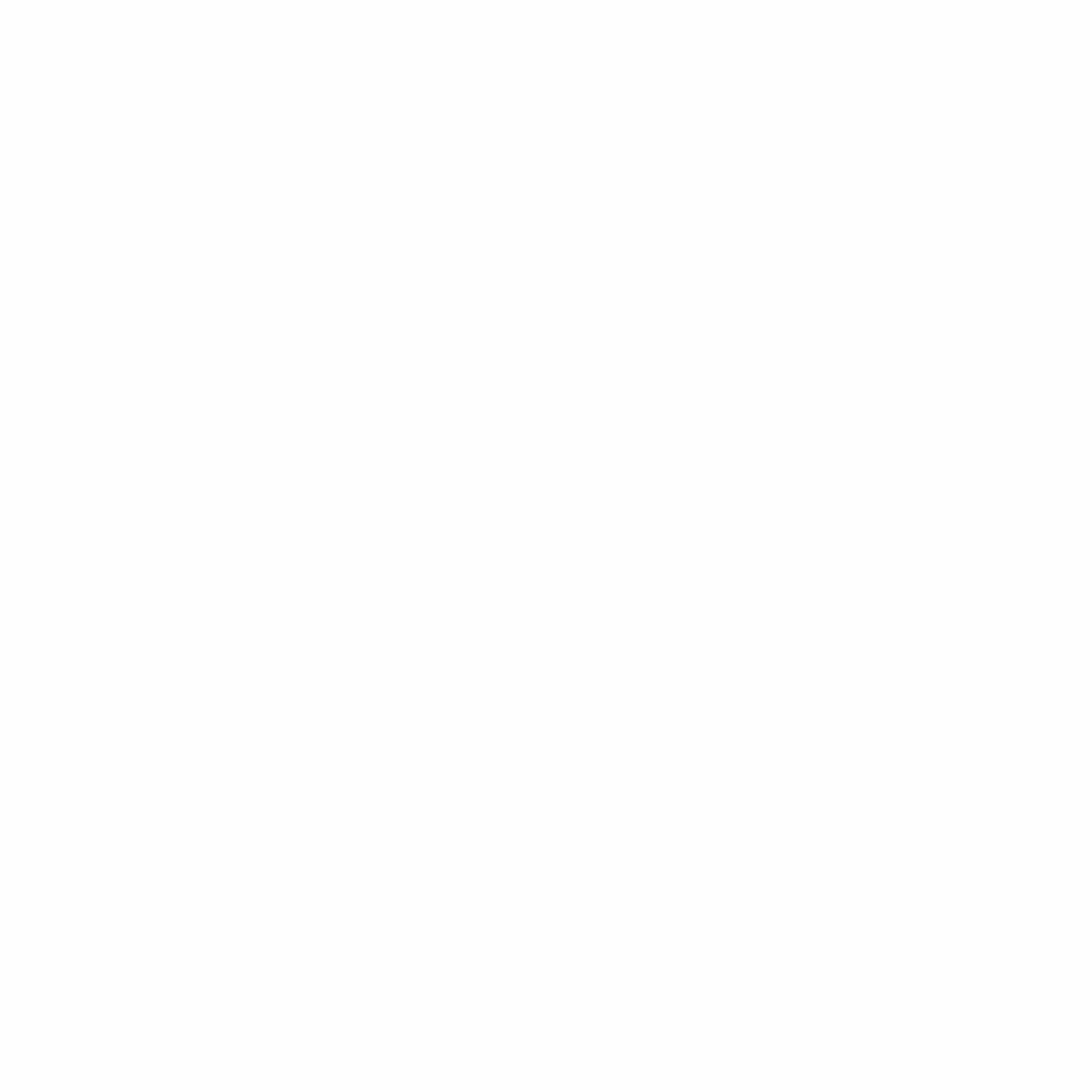In attesa che il testo della riforma della Giustizia approdi in Parlamento per la prima discussione, le interpretazioni sulla nuova normativa si rincorrono generando confusione e dubbi. Cerchiamo di fare chiarezza sulla riforma Cartabia con l’avvocato Riccardo Passeggi, esperto in diritto costituzionale.
di Alessandro Battaglia Parodi
Il testo andrà in discussione alle camere dal 23 luglio ed è ovviamente suscettibile di modifiche nel passaggio parlamentare. Quel che si sa per certo è che la nuova riforma stabilisce una durata massima di due anni per i processi in appello, mentre per quelli in corte di cassazione il tempo massimo previsto è di un anno, con possibilità di proroga per reati particolarmente gravi, rispettivamente di un anno in appello e sei mesi in cassazione.
Ma la riforma Cartabia non si ferma qui e interviene anche sui termini di durata delle indagini preliminari, sull’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero alla conclusione delle indagini, sui riti alternativi (abbreviato, patteggiamento, messa alla prova) e soprattutto sulla digitalizzazione e sul processo penale telematico, indicate dall’Ue come i fattori chiave dello snellimento burocratico.
Tanta roba, dunque. Nonostante ciò, tutti gli osservatori concordano sul fatto che la nuova prescrizione allungherà i processi anziché accorciarne i tempi. Cerchiamo allora di mettere ordine in questa complicata materia con l’aiuto dell’avvocato penalista Riccardo Passeggi, patrocinante in cassazione, già cultore della materia in Diritto costituzionale all’Università di Genova, nonché storico difensore di molti manifestanti costituitisi parti civili nel processo per gli abusi nella Scuola Diaz e nella caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova del 2001, di cui ricorre proprio in questi giorni il ventennale.
Avvocato, grazie all’istituto della prescrizione i responsabili di quella mattanza non hanno scontato neanche un giorno di carcere, nonostante si trattasse addirittura di atti di tortura. Qual è stata la magia?
«No, non corrisponde esattamente al vero che nessuno abbia scontato delle pene detentive. I principali imputati del processo Diaz hanno “pagato” con la detenzione domiciliare la condanna per il reato di falso in atto pubblico, passata in giudicato prima della prescrizione. E sarebbero finiti in carcere se l’indulto del 2006 non avesse pesantemente decurtato le loro pene. Stiamo dunque parlando di cose molto diverse».
Nelle intenzioni più genuine dei Costituenti la prescrizione doveva avere un ruolo di acceleratore del processo penale. Intenzione ampiamente disattesa, dal momento che oggi la prescrizione induce l’uomo della strada a pensare che un procedimento sia stato condotto inutilmente, con costi sociali ed economici altissimi.
«La prescrizione è, e allo stato dell’arte rimane, l’unico, efficace, acceleratore dei tempi del processo penale, oltre a costituire l’unico baluardo a presidio del principio costituzionale di “ragionevole durata del processo”. Quanto all’opinione comune, è semplicemente sbagliata. Nessun difensore, nessuno, è in grado di dilazionare i processi all’infinito. E le statistiche sulla prescrizione ci dicono che essa matura nella stragrande maggioranza dei casi nella fase delle indagini, là dove la difesa nulla ancora può per “allungare il brodo”. In concreto è tutta una questione di prassi degli uffici giudiziari. Se lavorano con celerità, e nel 90% dei casi basta volerlo, il problema non si pone».
Tuttavia c’è la comune convinzione che esistano due codici distinti, uno per chi può permettersi difensori in grado di allungare i processi all’infinito, veri maghi della dilazione, e l’altro per chi non ha questa fortuna. Non è così?
«Questo è in parte vero, ed è un fenomeno riconducibile all’introduzione del processo accusatorio di tipo anglosassone con il codice di procedura penale del 1989. Davvero una “roba da ricchi”, nel senso di costoso, vuoi per il cittadino, vuoi per la macchina della giustizia. Ma il problema si risolve a monte incentivando la deflazione del dibattimento, ovvero i riti alternativi: patteggiamento, rito abbreviato ecc. Ebbene, questo è tutto ciò che il Legislatore degli ultimi 20 anni si è ben guardato dal fare, anzi smantellando in larga parte la premialità dei riti alternativi, prevista dal testo originario del codice dell’89, sull’onda delle pulsioni “populiste” che costituiscono il retrostante ideologico della riforma Bonafede. Pare che la riforma Cartabia, da questo punto di vista, costituisca un’inversione di marcia. Vedremo se sarà davvero così».
Secondo lei i tempi stabiliti per i processi di secondo e terzo grado, così come previsti dall’emendamento Cartabia, sono sufficienti a portare i procedimenti a sentenza senza ingolfare ulteriormente la macchina della giustizia?
«Dipende dal funzionamento delle singole corti d’appello, la cui efficienza va valutata caso per caso. Per fare esempi concreti, a Genova e a Milano direi proprio di sì, sono sufficienti. A Roma e Torino direi di no. In cassazione sì, certamente, nonostante il rallentamento dovuto all’emergenza pandemica. In realtà è un problema di strutture, che vanno potenziate con più magistrati, più aule di udienza, più fotoscanner, più connessioni internet ad alta velocità, più personale di cancelleria e l’informatizzazione spinta del processo, ovvero informatizzare tutto tranne le udienze. I fondi del recovery plan dovrebbero servire proprio ed esattamente a questo, almeno lo si auspica».
Nell’ipotesi in cui i due anni per fare il processo d’appello trascorrano senza che si arrivi a sentenza, che fine fa la sentenza pronunciata in primo grado? Il reato non si può prescrivere perché la prescrizione è interrotta, ma la pena inflitta in primo grado non potrà essere eseguita. Insomma qualcuno rimarrà col cerino in mano…
«La cosa è un po’ più complicata. La prescrizione rimane interrotta dalla sentenza di primo grado, ma il processo si estingue. La riforma Cartabia incide infatti sul processo anziché sul reato. Quindi, in concreto, finisce tutto in un nulla di fatto. Questo meccanismo crea due grandi incertezze. La prima è relativa al fatto che l’azione penale è obbligatoria e irretrattabile per espresso disposto costituzionale. E come ha fatto notare Paolo Ferrua, insigne studioso e docente universitario di procedura penale, l’estinzione del processo derivante da inerzia del giudice, perché di questo si tratta, mal si concilia con il principio costituzionale. Quindi, che fare? Intervenire anche sul principio di obbligatorietà dell’azione penale, temperandolo? Vedremo cosa farà il Legislatore in questo senso. La seconda incertezza riguarda invece il danneggiato dal reato che si costituisce parte civile in giudizio, così esercitando nel giudizio penale l’azione di risarcimento danni, questione meramente civilistica ed estranea all’azione penale. Ebbene che cosa gli diciamo nel caso di estinzione del processo? Che era tutto uno scherzo? Questo è davvero un bel problema».
Ma non è che la Bonafede dava fastidio un po’ a tutti, destra e sinistra, e l’obiettivo era quello di ritornare alla normativa ex ante?
«Niente di tutto questo. Si tratta invece di un tema molto delicato che segna il limite del rapporto tra pubblico potere e individuo. Perché un sistema penale che tiene in ostaggio un imputato per una durata indefinita di tempo, semplicemente non può definirsi democratico. Bisogna partire da un presupposto, senza il quale ogni ragionamento sul tema è monco: la riforma Bonafede è di un’incostituzionalità greve, brutale, in quanto urta in maniera inconciliabile con il principio della “ragionevole durata del processo”, stabilito dall’art. 111 della costituzione, oltre che dalla convenzione europea dei diritti dell’uomo. Con la riforma Bonafede, dopo la sentenza di primo grado, con la prescrizione interrotta, i gradi successivi del giudizio possono durare quanto la vita dell’imputato. E questo è incostituzionale. In realtà, la problematica della legittimità costituzionale della riforma Bonafede non si è ancora posta in concreto in un giudizio, cosa che – non dovesse essere abrogata o modificata nel frattempo – accadrà tra diversi anni e cioè quando in appello o in cassazione arriverà un processo istruito per un reato commesso dopo l’1/1/20 e che sarebbe prescritto, se non ci fosse lo stop al decorso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Quando questo succederà, la sorte di questa infelice riforma sarà con ogni probabilità segnata. Per rispondere sinteticamente alla domanda, se l’obiettivo della riforma Cartabia è quello di correggere una grave stortura del sistema, non si può che salutarlo con favore: il problema è vedere ora “come” correggerla».
I maligni hanno letto in quel “occorre correggere gli squilibri della riforma Bonafede” esigenze non dichiarabili, come ad esempio riconoscere al Parlamento la possibilità di indicare alle procure i criteri generali da seguire per esercitare l’azione penale. Lei che ne pensa?
«Non credo ci siano altri motivi oltre a quanto esposto prima. L’interruzione della prescrizione sine die dopo la sentenza di primo grado è una tossina del sistema penale, in grado di inquinarne in maniera irrimediabile il funzionamento. Quindi è un bene che sia espulsa. Rispetto poi alle priorità nell’esercizio dell’azione penale, occorre dire che nella prassi è già così. È quindi lecito domandarsi se sia meglio che siano indicate con legge dal Parlamento, anziché essere decise in autonomia dai capi degli uffici di procura, come di fatto e non infrequentemente accade oggi».
La riforma Cartabia, presentata come garantista, è davvero così garantista?
«Impossibile dirlo adesso, quando ha appena iniziato l’iter parlamentare di approvazione. Si potrà dire qualcosa al riguardo una volta che sarà stata approvata ed entrerà in vigore».